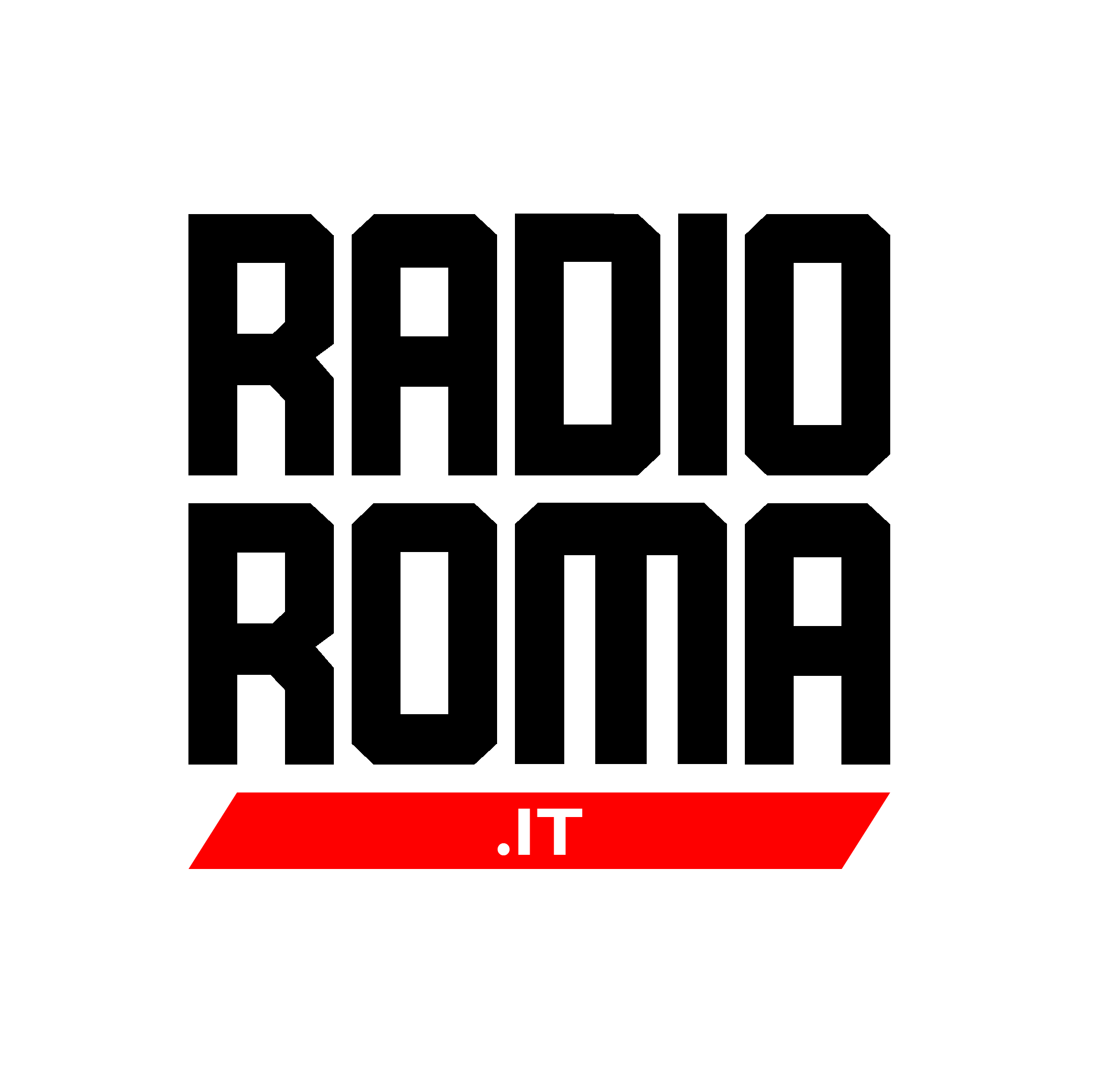ROMA – “Sin da ragazzo ho avuto una forte passione per il volo: ogni volta che vedevo un aereo in cielo provavo un’emozione che andava oltre la semplice curiosità, era la sensazione di qualcosa che volevo vivere in prima persona. Durante gli anni del liceo scientifico questa inclinazione si è trasformata in una convinzione: desideravo trasformare quel sogno in una professione vera, che non fosse fine a sé stessa, ma che avesse anche un valore più ampio, un senso di servizio verso il Paese. In parallelo ho sempre avuto una naturale predisposizione per le regole e la disciplina. Non le ho mai percepite come un limite, ma come un quadro di riferimento che ti permette di crescere, di misurarti con gli altri e con te stesso. Per questo, abbracciare la vita militare mi è sembrato quasi fisiologico, la scelta più coerente con il mio carattere e con i miei valori. A quel punto ho capito che se fossi riuscito a diventare un pilota militare avrei potuto unire due dimensioni fondamentali per me: la passione per il volo e la possibilità di metterla al servizio della collettività. L’idea che un giorno, attraverso la mia professione, avrei potuto contribuire concretamente al bene di altre persone è stata la spinta decisiva a intraprendere questo cammino”. Daniele si racconta in un’intervista all’agenzia Dire e ripercorre la sua carriera, il sogno, la prova dei fatti, la sua vita oggi e quel senso del ‘limite’, quel pionerismo che il volo nella sua meraviglia tecnologica porta con sè.
Come è avvenuto l’arruolamento?“L’arruolamento è stato il primo vero banco di prova. Dopo il liceo scientifico ho deciso di partecipare al concorso per entrare in Accademia Aeronautica: uno dei più selettivi d’Italia, con migliaia di candidati per pochi posti disponibili. Le prove erano numerose e severe: test di matematica, logica e cultura generale, accertamenti di lingua inglese, prove fisiche, valutazioni psicologiche, tirocinio comportamentale e colloqui individuali. Tutto lasciava pensare che l’Aeronautica Militare fosse alla ricerca di “superuomini” o “superdonne”, capaci di eccellere in ogni campo senza esitazioni. In realtà, con il tempo ho capito che non era così. Quelle prove servivano a misurare la determinazione e la tenuta di ciascun candidato, ma ciò che davvero conta non è la perfezione assoluta: l’Aeronautica cerca ragazzi e ragazze motivati, animati da solidi principi e valori morali, capaci di crescere lungo il percorso. Questo è ciò che fa la differenza, più ancora delle prestazioni fisiche o delle nozioni teoriche. Personalmente non ci sono riuscito al primo tentativo: ho dovuto riprovarci l’anno successivo, e nel frattempo mi sono iscritto a Ingegneria. Quell’esperienza mi ha dato metodo e maturità, qualità che si sono rivelate decisive quando finalmente ho superato il concorso ed ero pronto a intraprendere il percorso militare. Entrare in Accademia Aeronautica a Pozzuoli ha rappresentato un cambio radicale di vita: lasciare la famiglia, affrontare un contesto totalmente nuovo, con regole e ritmi serrati. È stata una sfida durissima, ma anche il passaggio fondamentale che ha segnato l’inizio del mio vero cammino da allievo ufficiale pilota’.
Qual è stato il suo percorso di carriera?’Dopo i cinque anni in Accademia Aeronautica a Pozzuoli, conclusi con la laurea in Scienze Aeronautiche – un corso creato appositamente per gli allievi ufficiali piloti insieme all’Università Federico II di Napoli – ho proseguito la mia formazione negli Stati Uniti, in Texas. Lì ho frequentato le scuole di volo per quasi due anni: un addestramento serrato, che mi ha portato al conseguimento del brevetto di pilota militare. È stato il passaggio dal sogno alla realtà, un momento che ancora oggi considero una delle tappe più significative della mia vita. Rientrato in Italia, sono stato assegnato al 14° Stormo, il mio primo reparto operativo. È stato un periodo fondamentale perché lì ho potuto toccare con mano cosa significhi davvero l’operatività della Difesa italiana. Non si trattava più di simulazioni o addestramenti, ma di missioni reali, spesso delicate, sia in patria che all’estero. È in quel contesto che ho imparato cosa voglia dire lavorare in squadra in ambienti complessi, portare a termine compiti che hanno ricadute dirette sulla sicurezza nazionale e confrontarmi con scenari dove la preparazione tecnica si intreccia con responsabilità istituzionali e geopolitiche. Al 14° Stormo ho capito che il mestiere del pilota militare non si limita a ‘volare’, ma è parte di un sistema più grande, che lavora silenziosamente per garantire la sicurezza del Paese. Successivamente ho avuto l’onore di entrare a far parte del 31° Stormo, un reparto di grande prestigio e delicatezza, deputato a svolgere missioni di trasporto sanitario urgente e di supporto alle più alte cariche dello Stato. Qui le responsabilità assumono un volto particolare: ogni volo può tradursi nella possibilità concreta di salvare una vita, oppure nel garantire la continuità operativa delle istituzioni del Paese. Si tratta di un impegno diverso rispetto a quello vissuto al 14° Stormo, ma non meno gravoso: cambia la natura della missione, non il livello di attenzione e dedizione richiesto. Il percorso è stato ed è tuttora impegnativo: richiede preparazione tecnica, freddezza nelle situazioni critiche e la capacità di mantenere un equilibrio tra vita privata e dovere professionale. Credo che proprio la resilienza e l’equilibrio siano qualità fondamentali, tanto quanto le abilità di volo, per affrontare una carriera in continua evoluzione e che non concede pause’.
Quali sono le principali difficoltà che ha incontrato?’Una moltitudine ma, a onor del vero, sono mutate nel tempo, accompagnando le diverse fasi del mio percorso. Quando sono entrato in Accademia avevo 19 anni: la prima vera prova è stata lasciare la mia famiglia d’origine e affrontare da solo un cammino ricco di incognite e con poche certezze. Era una scelta che, in un certo senso, significava separarsi per sempre dal contesto in cui ero cresciuto, per inseguire un sogno che poteva anche non realizzarsi. L’Accademia è stata un banco di prova volutamente durissimo: il suo obiettivo era tirar fuori il meglio da ciascuno di noi e trasformarci in Ufficiali. Non c’era spazio per mezze misure: disciplina, resistenza e capacità di crescere attraverso le difficoltà erano requisiti indispensabili. Poi è arrivato il corso negli Stati Uniti: un privilegio enorme, ma anche una sfida inedita. Nonostante anni passati a studiare inglese, trovarsi a usarlo ogni giorno in un contesto tecnico e complesso non è stato semplice. Tanto più che non lo si affrontava in un’aula, ma magari a testa in giù su un addestratore acrobatico, sorvolando le pianure del Texas. È stata un’esperienza che mi ha insegnato moltissimo sulla capacità di adattarmi e di superare i miei limiti. Rientrato in Italia ho dovuto confrontarmi con le responsabilità dell’impiego operativo. Qui le difficoltà hanno cambiato ancora volto: non più legate alla formazione, ma al peso delle missioni reali, spesso in contesti complessi anche dal punto di vista geopolitico. La pressione di sapere che ogni decisione ha conseguenze concrete, e che il livello di attenzione non può mai calare. Oggi, infine, la sfida è anche un’altra: conciliare questa vita con la sfera privata. Nel frattempo, infatti, mi sono sposato e sono diventato genitore. Il mestiere del pilota militare richiede dedizione assoluta, e trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia è forse la difficoltà più grande, ma anche quella che più di tutte ti ricorda per chi e per cosa stai facendo questo percorso’.
Guardando al presente, quali aspetti del suo lavoro ritiene più impegnativi?’Oggi le sfide non sono più quelle legate alla formazione o all’addestramento, ma quelle della professione quotidiana. Lo paragono spesso al mestiere del chirurgo: la conoscenza teorica è indispensabile, ma da sola non basta. Serve esperienza, serve esercizio costante, serve la capacità di reagire con lucidità in situazioni in cui non c’è il tempo di consultare un manuale o di pensarci due volte. Come per un chirurgo in sala operatoria, anche per un pilota ogni decisione ha conseguenze immediate e dirette. Sono professioni in cui l’errore è poco tollerato, perché in gioco c’è sempre la vita di altre persone. Questo significa convivere con un alto livello di pressione: non basta sapere, bisogna saper applicare ciò che si conosce in condizioni mutevoli, a volte estreme, mantenendo sangue freddo e lucidità, arrivando a prendere rapidamente decisioni con pochi elementi a disposizione. Oggi come ieri, la difficoltà maggiore credo sia quella di riuscire a mantenere l’equilibrio tra lo studio e l’aggiornamento continuo da un lato, e l’esperienza sul campo dall’altro. In questo, l’Aeronautica Militare ha un ruolo decisivo: fornisce ai propri piloti un addestramento di prim’ordine, che considero ancora oggi superiore a quello disponibile negli ambiti civili. È proprio questa preparazione, fatta di rigore e realismo, a permetterci di affrontare con sicurezza le sfide e le responsabilità che il nostro mestiere comporta’.
Cosa rappresenta per lei essere oggi al 31° Stormo?’Un traguardo ma anche una responsabilità quotidiana. È un reparto di grande prestigio, che svolge missioni uniche per delicatezza e importanza: dal trasporto sanitario d’urgenza, dove ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte di una persona, al trasporto delle più alte cariche dello Stato. Ogni volo è diverso dall’altro: a volte ci si trova a partire nel cuore della notte per un’emergenza sanitaria, altre volte si pianificano missioni internazionali con tempi stretti e protocolli da rispettare al millimetro. In entrambi i casi, ciò che accomuna queste esperienze è la consapevolezza di svolgere un servizio che va oltre il singolo pilota o l’equipaggio: è un impegno diretto verso la collettività e verso lo Stato. Arrivarci non è stato semplice, ma proprio le tappe precedenti – l’Accademia, la formazione negli Stati Uniti, l’esperienza al 14° Stormo – mi hanno preparato a gestire la complessità e le responsabilità che il 31° richiede. Se penso al ragazzo di 19 anni che lasciava casa con più sogni che certezze, vedo oggi un percorso fatto di sacrifici, di errori e di lezioni apprese, che mi hanno portato a essere qui. Oggi il significato più profondo è proprio questo: sentirmi parte di un ingranaggio che funziona non per ambizione personale, ma per garantire un servizio essenziale al Paese. E allo stesso tempo, cercare ogni giorno quell’equilibrio tra dedizione al dovere e presenza nella mia famiglia, perché so che entrambe le dimensioni danno valore a quello che faccio’.
Cosa si prova a svolgere missioni di trasporto sanitario urgente?’Sono tra le missioni più impegnative ma anche più gratificanti. In quei momenti senti in modo tangibile quanto il tuo lavoro possa incidere sulla vita di una persona e della sua famiglia. Ogni minuto conta, e questo ti spinge a dare il massimo in termini di prontezza, precisione e coordinazione con tutto il team, a terra e in volo. Non c’è spazio per esitazioni: sai che dietro a quel volo ci sono speranze, attese e spesso la possibilità concreta di salvare una vita. Molto spesso si tratta di bambini piccolissimi, a volte di soli pochi giorni di vita. È forse la parte più delicata, perché insieme ai piccoli pazienti imbarchiamo anche i genitori, che stanno vivendo il trauma e l’angoscia di un dolore che non dovrebbe mai toccare un neonato. Da genitore, non è facile rimanere impermeabile: la serenità che vivo a casa con la mia famiglia si scontra con lo sguardo di chi in quel momento si aggrappa a ogni brandello di speranza. Ed è proprio qui che tutto prende senso: tutte le ore di volo, le missioni di addestramento più difficili, i mesi lontani da casa trascorsi ad addestrarsi, persino le chiamate nel cuore della notte… tutto si concretizza in quella possibilità che noi diamo a quelle famiglie, facendo decollare fisicamente la speranza. In quei momenti sono anche consapevole di incarnare, in prima persona, il volto dello Stato. Uno Stato che spesso i cittadini percepiscono come distante o assente, ma che in realtà, proprio nel cuore della notte, muove aerei, equipaggi ed équipe mediche per salvare una vita. Sentire di rappresentare concretamente questa presenza dà un significato ancora più profondo al mio lavoro, e lo rende una responsabilità che porto con orgoglio’.
Che consigli darebbe a quei ragazzi e ragazze che guardano con ambizione al mestiere che lei oggi svolge?’Direi innanzitutto di non idealizzare troppo questo mestiere, ma di viverlo come un percorso fatto di impegno, sacrifici e tanta costanza. Diventare pilota militare non è un privilegio riservato a pochi supereroi: io stesso ho dovuto tentare più volte per riuscirci. È un cammino duro, che può sembrare a tratti insormontabile, ma non bisogna lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà iniziali. Un aspetto importante è informarsi bene, per capire davvero cosa significhi essere un pilota militare. Non si tratta solo di volare, ma di abbracciare una vita fatta di disciplina, studio continuo, spirito di squadra e senso del dovere. È un mestiere che porta con sé soddisfazioni immense, ma che richiede anche sacrifici e rinunce, personali e familiari. Occorre avere una grande motivazione interiore, perché sarà quella a sostenerti nei momenti di stanchezza e nei periodi più difficili. Il consiglio più grande che posso dare è di crederci senza riserve, ma anche di essere pronti a imparare continuamente, a rialzarsi dopo gli insuccessi e a non perdere mai di vista il perché si è scelta questa strada. Alla fine, la ricompensa più grande non è solo quella di pilotare un aereo, ma di farlo sapendo che ogni volo ha un valore concreto per il proprio Paese e per le persone che ne fanno parte’.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it